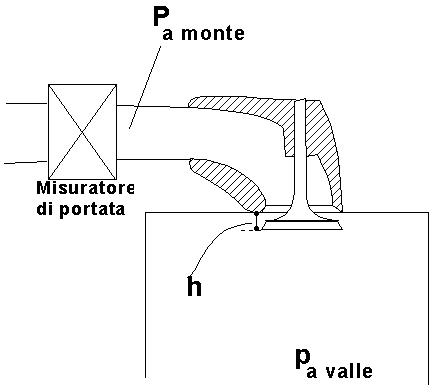
Figura 1: Elementi costituenti un banco di flussaggio. |
Le valvole nel loro moto mettono a disposizione dei
gas una sezione di passaggio di area variabile. Le condizioni di efflusso
attraverso la valvola costituiscono un fenomeno piuttosto complesso perché in
prossimità del fungo della valvola stessa i gas subiscono una forte deflessione
causa di irreversibilità e turbolenze.
Un'analisi accurata può essere condotta con codici
numerici di simulazione della gasdinamica tridimensionale o tramite
sperimentazione con tecniche di visualizzazione quali l'anemometria laser. Al
motorista più spesso interessa poter definire dei parametri globali che
sintetizzino i complessi fenomeni in gioco e forniscano delle utili indicazioni
in fase di progettazione.
Per questo quella che di solito viene definita è la "permeabilità" del complesso valvola‑sede o della testata del motore nel suo insieme, cioè l'attitudine della valvola a far fluire una portata di gas tra due ambienti a pressione diversa. La permeabilità viene misurata sui cosiddetti banchi di flussaggio che possono essere schematizzati come in figura.
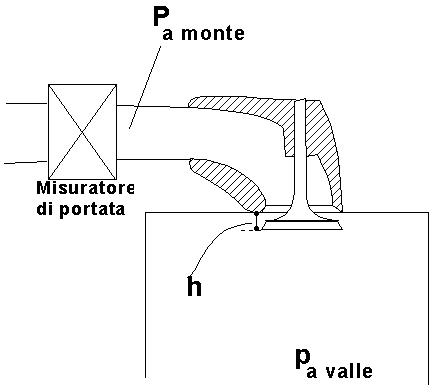
Figura 1: Elementi costituenti un banco di flussaggio. |
La testata viene collegata, da un lato con un
ambiente in cui regna la pressione totale
![]() (cioè in condizioni stazionarie) e
dall'altro con un ambiente a pressione
(cioè in condizioni stazionarie) e
dall'altro con un ambiente a pressione
![]() (dove il fluido è in moto) e la
portata massica di aria viene misurata per diverse posizioni dell'alzata valvola
(dove il fluido è in moto) e la
portata massica di aria viene misurata per diverse posizioni dell'alzata valvola
![]() , cioè dello spostamento in direzione assiale dalla posizione di riposo. Se
durante la misura l’alzata della valvola è costante, si parla di banco di
flussaggio stazionario, se invece la valvola è mantenuta in movimento
dall’albero a camme, l’apparecchiatura si chiama banco di flussaggio
instazionario o dinamico. La portata così misurata viene confrontata con la
portata che fluirebbe in condizioni isentropiche attraverso un ugello di sezione
"equivalente". Tale ugello non è però definito in modo univoco:
alcuni ricercatori assumono come ugello equivalente quello di area pari all'area
della sezione normale del condotto in corrispondenza della valvola (
, cioè dello spostamento in direzione assiale dalla posizione di riposo. Se
durante la misura l’alzata della valvola è costante, si parla di banco di
flussaggio stazionario, se invece la valvola è mantenuta in movimento
dall’albero a camme, l’apparecchiatura si chiama banco di flussaggio
instazionario o dinamico. La portata così misurata viene confrontata con la
portata che fluirebbe in condizioni isentropiche attraverso un ugello di sezione
"equivalente". Tale ugello non è però definito in modo univoco:
alcuni ricercatori assumono come ugello equivalente quello di area pari all'area
della sezione normale del condotto in corrispondenza della valvola (
![]() ), altri invece scelgono l'area della superficie cilindrica con diametro di base
pari al diametro massimo della valvola ed altezza uguale all'alzata valvola (
), altri invece scelgono l'area della superficie cilindrica con diametro di base
pari al diametro massimo della valvola ed altezza uguale all'alzata valvola (
![]() )
)
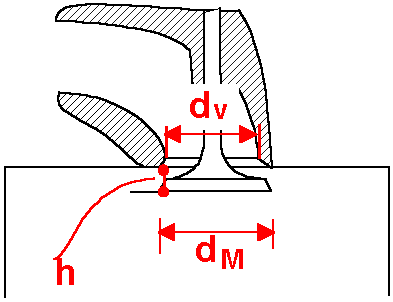
Figura 2: Particolare delle grandezze geometriche caratteristiche della sezione del condotto in prossimità della sede valvola. |
La differenza fondamentale quindi tra le due
convenzioni risiede nell'aver scelto una sezione di riferimento costante nel
primo caso e variabile con l'alzata nel secondo.
Il rapporto tra la portata misurata e la portata
ideale di riferimento genera un coefficiente adimensionale che viene chiamato coefficiente
di efflusso. Il coefficiente di efflusso ottenuto utilizzando la prima delle
due portate di riferimento (quella con un'area costante) verrà indicato con
Cd
nel seguito, mentre quello ottenuto
utilizzando la seconda (area variabile con l'alzata) verrà indicato con
Cdf
.